Cosa sta succedendo davvero
Ogni mattina leggiamo su LinkedIn almeno tre post su come l’IA “rivoluzionerà tutto”. Ogni sera sentiamo qualcuno dire che “i robot ci ruberanno il lavoro”. La verità, come spesso accade, sta nel mezzo ed è più interessante di entrambe le narrazioni.
Abbiamo passato gli ultimi mesi a studiare i dati più recenti su intelligenza artificiale e mercato del lavoro. Quello che emerge non è né l’apocalisse né un’utopia, ma un quadro complesso che vale la pena esplorare senza troppi allarmismi.
Il punto di partenza sono due report che tutti citano ma pochi leggono davvero: il “Future of Jobs Report 2025” del World Economic Forum e lo studio “Superagency in the workplace” di McKinsey. I numeri che contengono sono sorprendenti, ma vanno interpretati.
Secondo il WEF, entro il 2030 nasceranno 170 milioni di nuovi posti di lavoro, mentre ne spariranno 92 milioni. Il saldo? +78 milioni di impieghi. Sembra una buona notizia, no? Il problema è che questi numeri raccontano una storia più sfumata di quanto appaia.
McKinsey stima che l’IA potrebbe generare fino a 4,4 trilioni di dollari l’anno grazie all’aumento della produttività. È una cifra che fa girare la testa, ma solleva una domanda cruciale: chi beneficerà di questa ricchezza extra?

Settori: alcuni corrono, altri arrancano
Non tutti i settori stanno vivendo la stessa trasformazione. Abbiamo provato a mappare quello che sta succedendo:
Tecnologia e finanza: sono ovviamente in prima linea. Microsoft ha già integrato l’IA in quasi tutti i suoi prodotti, JPMorgan usa algoritmi per analizzare rischi che un tempo richiedevano team di analisti. Ma qui c’è un paradosso: le aziende che sviluppano l’IA sono anche quelle che ne traggono maggiori benefici. E non è esattamente una sorpresa.
Sanità e manifattura: stanno sperimentando, con risultati altalenanti. La diagnostica assistita fa progressi impressionanti, ma implementarla su larga scala richiede investimenti che non tutti possono permettersi. Nelle fabbriche, i robot collaborativi stanno cambiando il lavoro delle catene di montaggio, ma creano anche nuovi ruoli di supervisione che richiedono competenze diverse.
Retail, trasporti e istruzione: si muovono più lentamente. L’IA per personalizzare l’esperienza cliente funziona, ma non è ancora così diffusa come si legge sui giornali. Nelle scuole, gli insegnanti iniziano a usare strumenti di IA, spesso senza una formazione adeguata.
Edilizia: rimane il settore meno toccato. Ed è interessante: mentre tutti parlano di rivoluzione digitale, chi costruisce case e ponti continua a fare il proprio lavoro più o meno come sempre.
In questo scenario, non tutti avranno le stesse opportunità. Un ingegnere con competenze di IA troverà spazio anche domani. Ma chi lavora in un settore tradizionale, senza possibilità di aggiornarsi, farà più fatica. È qui che entra in gioco la vera leva del cambiamento: le competenze. Quelle che oggi sono richieste, e soprattutto quelle che serviranno domani.

Le competenze che contano (e quelle che conteranno)
Qui la situazione si fa intrigante. I dati mostrano che serviranno sempre più competenze legate a cybersecurity, big data e programmazione avanzata. Niente di nuovo sotto il sole,
ma c’è un aspetto che ci ha colpito: per la prima volta, le “competenze legate alla sostenibilità e alla responsabilità ambientale” sono entrate tra le 10 skill in più rapida crescita. Non è solo una questione di greenwashing – le aziende si stanno rendendo conto che innovazione tecnologica e sostenibilità viaggiano di pari passo.
E poi ci sono le soft skill. Creatività, pensiero critico, capacità di adattamento: tutto quello che l’IA (almeno per ora) non sa fare bene. È paradossale, ma mentre le macchine diventano più intelligenti, le qualità umane diventano più preziose.
Il problema è che sviluppare queste competenze richiede tempo e investimenti. Il 92% delle aziende dice di voler aumentare gli investimenti in IA nei prossimi tre anni, ma solo l’1% ritiene di aver raggiunto una “maturità” nell’uso di queste tecnologie. È un po’ come dire: “Vogliamo correre la maratona, ma non sappiamo ancora allacciarci le scarpe”.
Chi vince e chi perde (e perché non è così semplice)
La domanda da 4,4 trilioni di dollari è: come si distribuiranno questi benefici?
I dati suggeriscono che le disuguaglianze potrebbero aumentare su più livelli:
- Tra lavoratori altamente qualificati e quelli con competenze di base
- Tra settori tecnologici avanzati e settori tradizionali
- Tra paesi ricchi e paesi in via di sviluppo
- Tra aziende innovative e aziende in ritardo
Ma non è detto che vada per forza così. Molto dipenderà dalle scelte che faremo nei prossimi anni.
L’Unione Europea ha fatto il primo passo serio con l’AI Act, entrato in vigore il 1° agosto 2024. È il primo tentativo di regolamentare l’IA a livello globale, e gli altri paesi ci stanno guardando con attenzione. Certo, i regolamenti sono spesso in ritardo rispetto alla tecnologia, ma almeno si inizia a parlarne.
Quello che possiamo fare (senza illuderci di avere tutte le risposte)
Dopo aver analizzato tutti questi dati, abbiamo un’idea di cosa potrebbe funzionare:
Per chi lavora: investire nella formazione continua non è più un’opzione, è una necessità. Ma non solo su competenze tecniche – anche su quelle relazionali e creative. E soprattutto, smettere di vedere l’IA come un nemico. È più utile capire come usarla per fare meglio il proprio lavoro che contrastarla.
Per le aziende: l’approccio “sostituiamo le persone con le macchine per risparmiare” è miope. Le aziende che stanno avendo più successo sono quelle che usano l’IA per potenziare i dipendenti, non per rimpiazzarli. Richiede più investimenti iniziali, ma i risultati a lungo termine sono migliori.
Per i governi: servono politiche di riqualificazione su larga scala e sistemi di protezione sociale più flessibili. Le transizioni non si gestiscono da sole, e aspettare che “il mercato si regoli” non è una strategia.
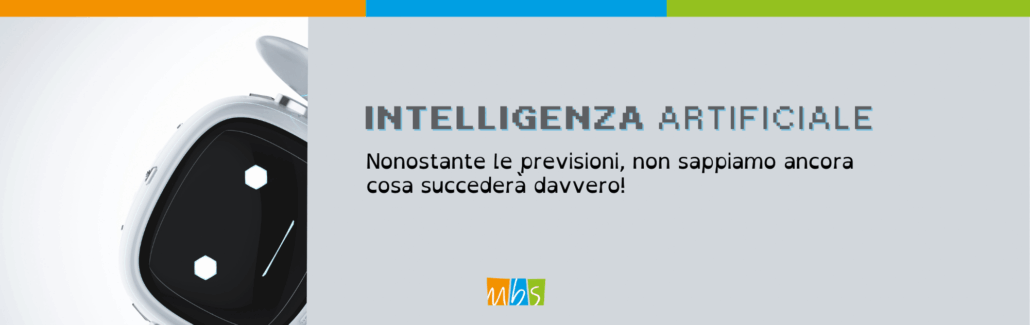
Tre scenari possibili (e perché ci auguriamo che non si realizzi il terzo)
Scenario ottimista: L’IA diventa davvero un moltiplicatore di capacità umane: ci aiuta a lavorare meglio, non a lavorare di più. Le lavoratrici e i lavoratori vengono riqualificati con successo, la produttività aumenta e i benefici vengono distribuiti in modo equo attraverso politiche pubbliche intelligenti. Nascono nuovi tipi di lavoro che oggi non riusciamo nemmeno a immaginare.
Scenario realistico: L’adozione dell’IA procede a velocità diverse: chi ha le risorse si adatta, chi non le ha resta indietro. Ci sono vincitori e perdenti, ma nel complesso la transizione è gestibile. I governi implementano politiche di sostegno che attutiscono i colpi peggiori.
Scenario pessimista: L’IA viene usata principalmente per tagliare i costi del lavoro. I benefici si concentrano nelle mani di pochi. Le disuguaglianze aumentano drammaticamente. I governi non riescono a tenere il passo con i cambiamenti e le tensioni sociali crescono.
Quale scenario si realizzerà dipende dalle scelte che stiamo facendo adesso. Non è scritto da nessuna parte che debba andare male, ma serve consapevolezza.
Quello che non sappiamo (e che dovremmo ammettere)
Nonostante tutti questi dati e previsioni, ci sono domande fondamentali a cui non sappiamo ancora rispondere:
- L’IA continuerà a migliorare al ritmo attuale o rallenterà?
- Quanto tempo serve davvero per riqualificare milioni di lavoratori/lavoratrici?
- I nuovi lavori che nasceranno saranno davvero accessibili a tutte le persone?
- Come reagiranno le società a cambiamenti così rapidi?
L’onestà intellettuale richiede di ammettere che stiamo navigando in acque inesplorate. I dati ci danno una bussola, ma la destinazione finale rimane incerta.
Non abbiamo tutte le risposte — e forse è proprio da qui che dobbiamo partire. L’intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro, la società e il modo in cui ci pensiamo come esseri umani. Ma non sarà un algoritmo a dirci dove andare: lo decideremo noi, con le scelte che facciamo (adesso).
Affrontare questo cambiamento richiede lucidità, coraggio e un po’ di sistemi capaci di adattarsi a ciò che ancora non conosciamo. Non è poco, ma nemmeno troppo per una sfida così grande. Perché l’IA non è solo una questione di tecnologia: è una questione profondamente umana.
Testo a cura di Fabrizio Palai, Matteo Campione e Gaia Raisoni

